di Mario Bozzi Sentieri
“Disaffiliazione”: abituiamoci a convivere e a fare i conti – come singoli e socialmente – con questo termine, capace di identificare la nuova crisi relazionare, la distanza tra le persone, l’isolamento di un mondo “al singolare”.
“La perdita delle relazioni fisiche è un rischio per la società: cresce il senso di abbandono e aumenta il risentimento. Sottotraccia, quasi senza far rumore, sta cambiando la trama delle nostre relazioni sociali”: a denunciare questa crisi Mauro Magatti, in un recente articolo pubblicato sul “Corriere della sera” (“Troppo social, pochi incontri: la solitudine come nuova disuguaglianza sociale”). Magatti, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sociologo ed economista, si occupa da tempo del rapporto tra economia e società, studiando la trasformazione del capitalismo contemporaneo, visto come una costruzione storico-sociale che combina apparati tecno-economici, assetti politico-istituzionali e visioni culturali. Dal saggio del 2003 (con Chiara Giaccardi) L’ io globale. Dinamiche della socialità contemporanea Magatti è stata costante nella sua analisi/denuncia rispetto ad una società che è uscita fuori dai suoi argini tradizionali, vivendo in una dimensione post-societaria, fluida, in un difficile rapporto tra la dimensione micro dell’esperienza personale e la dimensione macro, legata agli assetti economici, tecnologici e istituzionali.
La perdita delle relazioni fisiche – nota Magatti – è un rischio per la società: cresce il senso di abbandono e aumenta il risentimento, fino a cambiare la trama delle nostre relazioni sociali. Da qui la “disaffiliazione”.
A confermarlo il nuovo rapporto dell’OCSE dal titolo “Social Connections and Loneliness in OECD Countries”, il quale analizza come le connessioni sociali, quindi le relazioni e le interazioni tra le persone, influenzino aspetti fondamentali della vita, come salute, lavoro, istruzione e partecipazione civica. Basato sui risultati della principale pubblicazione dell’OCSE sul benessere “How’s Life?,” il documento offre un quadro aggiornato sulla quantità e qualità dei legami sociali nei Paesi OCSE. Dallo studio emerge come le persone si incontrino di persona sempre meno. In particolare, uomini e giovani mostrano un calo significativo nelle relazioni sociali, e la mancanza di connessioni tende a concentrarsi tra chi vive solo, ha difficoltà economiche o è anziano. La vita sociale diventa sempre più frenetica e allo stesso tempo più rarefatta. Come atomi accelerati, abbiamo molte più interazioni, ma sempre meno relazioni. Nel mondo dove tutto è funzione, si riducono gli spazi di socialità spontanea.
Il rapporto evidenzia inoltre che fattori come le infrastrutture sociali e le tecnologie digitali possono favorire o indebolire i legami tra le persone, indicando ambiti chiave su cui intervenire per le future politiche pubbliche. Non c’è da sorprendersi – nota Magatti: “a ogni tecnogenesi segue un’antropogenesi. Le piattaforme social hanno reso più facile comunicare, ma anche più raro incontrarsi. Ci si scambia messaggi, si condividono immagini, si commentano post. Ma diventa più rara l’esperienza concreta dell’altro. E se i social hanno fatto esplodere le interazioni facendo venire a galla anche tutto ciò che di brutale alberga nell’animo umano, ora con l’AI entriamo nell’epoca della sostituzione della relazione umana con la relazione uomo-macchina”. In questo tipo di tendenze un peso rilevante lo hanno certamente la demografia e le forme della convivenza. Aumentano i nuclei composti da una sola persona, soprattutto tra gli anziani, ma anche tra i giovani adulti. Oggi quasi un terzo delle famiglie italiane è formato da un solo individuo. A Milano, come in tutte le grandi città occidentali, siamo oltre il 50 per cento. La famiglia, che per generazioni è stata la principale rete di protezione e di socialità, è oggi più piccola, fragile e instabile. In Gli otto peccati capitali della nostra civiltà Konrad Lorenz lo aveva capito già nel 1973, anno del Premio Nobel, assegnatogli per la medicina e la fisiologia, elencando ed analizzando “scientificamente” i fattori che mettono a rischio la stessa esistenza della nostra specie: lo squilibrio demografico, l’inquinamento e il saccheggio delle risorse naturali, lo stress “competitivo”, l’estinguersi dei sentimenti, la perdita del patrimonio culturale e la mancanza del modello paterno, l’indottrinamento di massa (attraverso i mass-media), il rischio atomico. Pensiamo alle sue polemiche sulle dottrine “pseudo democratiche” e ai processi di disumanizzazione. Temi enormi, affrontati in L’altra faccia dello specchio (Adelphi, 1974), laddove Lorenz riesce ad andare al cuore della crisi contemporanea, sezionata con chirurgica lucidità, a partire dalla patologia delle megalopoli, per arrivare alla “degradazione del comportamento sociale ereditario” e alla scomparsa dell’amore tradizionale. Pensiamo ancora al problema attualissimo dell’aggressività, affrontato, in modo originale, in Il cosiddetto male (Il Saggiatore, 1969), problema che Lorenz si sforza di liberare dalle sue componenti emozionali, rintracciando le origini filogenetiche dell’impulso aggressivo e denunciando le sue condizioni e le sue manifestazioni.
A ben guardare – aggiungiamo noi – la “disaffiliazione” appartiene all’ideologia individualista che ha informato l’ultimo ventennio del Novecento, proiettando le sue ombre sul Terzo Millennio. E’ molto più di un sistema economico-sociale. E’ una mentalità che ha permeato i popoli, destrutturando le società ed uccidendo anche la politica. Non a caso Zygmunt Bauman, il teorico della modernità liquida, segnata dall’incertezza, dalla precarietà, dall’isolamento, ha evidenziato il riemergere della voglia di “communitas”, costruita sui rapporti interpersonali e sul contatto diretto tra le persone (così come teorizzato, alla fine del XIX secolo, da Ferdinand Tönnies) seppure declinata con la “societas”, strutturata sui rapporti a distanza. In questo contesto il “nemico principale” sono soprattutto i processi di disintermediazione attraverso i quali si è realizzato il depotenziamento dei corpi intermedi. Alla base di questi processi l’idea che l’individuo sia il migliore giudice di sé stesso e dunque non abbia bisogno di “intermediari”, sia in campo politico che sociale e culturale. Il singolo è così decontestualizzato rispetto alle appartenenze sociali (familiari, territoriali, aziendali, di categoria), diventando il figlio di una società in cui a dettare legge sono l’individualismo e lo sradicamento. Con il risultato di trasformare la solitudine in un tema politico, a tal punto significativo da spingere qualcuno ad intitolare questo nostro secolo alla solitudine. L’augurio ovviamente è che ciò non accada. Di ben altre suggestioni abbiamo bisogno e di ben altre speranze, per uscire da questo lockdown psicologico. Soprattutto di risposte ad una domanda di appartenenza che va ricostruita in ragione di rinnovati valori fondanti, incardinati storicamente intorno all’idea di famiglia, di Patria, di solidarietà sociale. Più che di palliativi c’è insomma bisogno di esempi e di una nuova consapevolezza collettiva, intorno a cui “ritrovarsi”. E quindi, ben al di là della politica, di una nuova metapolitica, in grado di promuovere e rendere concreta una visione della vita e del mondo alternativa a quella corrente.

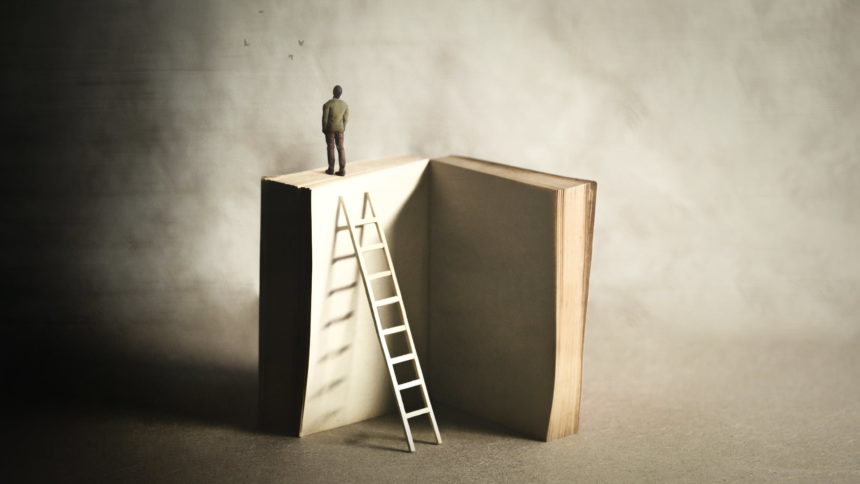
Lascia un commento